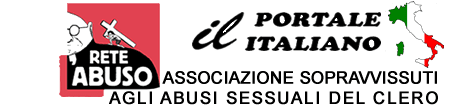Nel dibattito sulla violenza sessuale si continua troppo spesso a confondere la semplificazione con la chiarezza. Ma quando il diritto rinuncia alla complessità della realtà umana, smette di proteggere e inizia a esporre. È in questo spazio che si colloca la proposta della senatrice Bongiorno della Lega: non come intervento tecnico neutro, ma come scelta culturale che incide direttamente sulla possibilità stessa delle vittime di accedere alla giustizia.
Nel diritto penale il consenso sessuale non è una parola pronunciata nel vuoto, ma l’espressione effettiva dell’autodeterminazione della persona. Per essere giuridicamente valido, il consenso deve essere libero, attuale e consapevole, come impongono la Convenzione di Istanbul, la giurisprudenza della Corte EDU e la costante elaborazione della Cassazione, in linea con i più avanzati ordinamenti europei, come Francia e Germania, che hanno fatto del rispetto della volontà della persona e della protezione contro ogni forma di coercizione il vero indice di civiltà giuridica. Basti pensare al caso Gisèle Pelicot in Francia, in cui la vittima fu narcotizzata dal marito e ripetutamente esposta a rapporti sessuali senza poter acconsentire, evento che ha determinato una riforma legislativa inserendo esplicitamente il consenso libero come elemento essenziale dei reati sessuali.
In Germania, il §177 del Codice penale tutela in maniera altrettanto avanzata la volontà discernibile della vittima, punendo gli atti sessuali anche in assenza di violenza fisica quando la persona non è in grado di esprimere un dissenso effettivo, ad esempio per shock, intossicazione o soggezione. Rispetto a questo modello europeo, la proposta Bongiorno rischia di riportare l’Italia a un approccio arretrato: il reato si fonda sul dissenso e non sulla presenza di un consenso libero e attuale, imponendo alla vittima l’onere di dimostrare la propria opposizione.
La violenza sessuale può dunque sussistere anche in assenza di violenza fisica o di minacce esplicite, quando l’agente approfitti di una condizione di inferiorità psichica o di un contesto idoneo a comprimere la libertà di autodeterminazione della vittima.
In presenza di stati di shock, dissociazione, freezing, soggezione o intimidazione ambientale, anche un apparente “sì” è giuridicamente privo di valore, perché non esprime una volontà libera ma una risposta traumatica di adattamento o di sopravvivenza. Il trauma dissociativo che imperversa sulle vittime incide profondamente sulla memoria rievocativa: la frammentazione del ricordo, le amnesie selettive, le discontinuità narrative che possono emergere dalle indagini preliminari all’incidente probatorio fino al controesame dibattimentale non sono segni di inattendibilità, ma l’impronta stessa della violenza subita. Pretendere, in tali condizioni, un dissenso esplicito e una narrazione lineare significa imporre alla vittima un modello normativo di “reazione corretta”, già respinto dalla giurisprudenza, e trasformare il processo in un dispositivo di esposizione anziché di tutela.
In questo squilibrio strutturale, l’autore si muove come chi agisce in piena luce mentre la vittima resta confinata in uno spazio privo di vie d’uscita: scambiare quella paralisi o quella acquiescenza per consenso equivale a confondere la costrizione con la scelta. È proprio questo impianto di civiltà giuridica che la proposta Bongiorno tenta di scardinare, reintroducendo un paradigma culturale che alimenta la sfiducia nella giustizia e amplifica il rischio di vittimizzazione secondaria, fatta di interrogatori insinuanti e colpevolizzanti — perché non è scappata, perché non ha urlato, perché non ha chiesto aiuto, ma perché si è vestita in quel modo… — riportando il processo a essere un giudizio sulla condotta della vittima più che sull’abuso dell’autore.
Si tratta di un arretramento culturale grave e pericoloso, che vanifica le conquiste delle donne sul terreno dell’autodeterminazione e della dignità, ma che investe l’intera comunità democratica, uomini compresi, perché indebolisce i presìdi dello Stato di diritto e normalizza l’idea che la libertà personale possa essere compressa senza responsabilità. Dove il consenso smette di essere il confine invalicabile, non arretrano solo i diritti delle donne: arretra la democrazia.
Difendere il consenso sessuale come limite inviolabile non è solo una questione giuridica: è un atto di responsabilità civile e politica. È urgente alimentare il dibattito pubblico e la mobilitazione civile, chiedendoci se questo attacco ai diritti delle vittime — alla loro parola, libertà e dignità — non sia collegato alle stesse logiche del referendum sulla divisione delle carriere dei magistrati, che rischiano di comprimere l’indipendenza della giustizia e la tutela effettiva dei diritti. Difendere il sì che protegge significa difendere lo Stato di diritto, dire chiaramente che la giustizia deve stare dalla parte di chi subisce violenza e non di chi la perpetra. È il momento di far sentire la nostra voce, di interrogarsi, di mobilitarsi: perché la libertà, la dignità e la tutela delle vittime non siano mai sacrifici negoziabili nel gioco della politica.
Roma, 25/01/2026
Avv. Mario Caligiuri
(RESP. DELL’OSSERVATORIO PER LA TUTELA DELLE VITTIME DI RETE L’ABUSO)