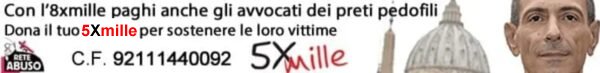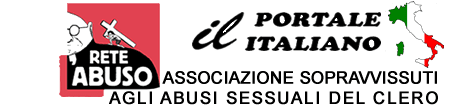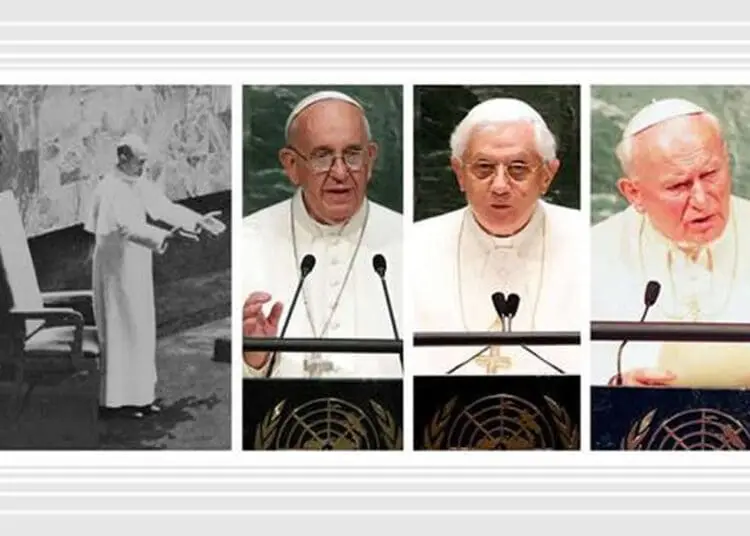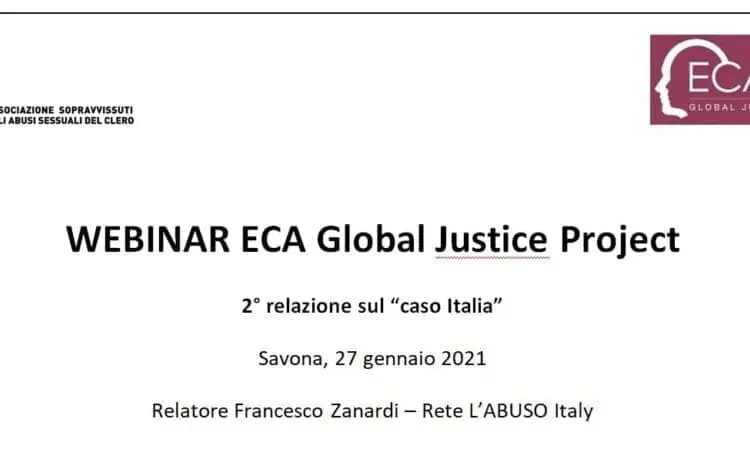La separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri viene presentata come riforma tecnica e garantista. In realtà incide sul nucleo costituzionale dell’ordinamento giudiziario: l’unità della magistratura delineata dall’art. 104 Cost.. Tale unitarietà assicura che giudici e PM condividano cultura professionale, limiti comuni e un unico CSM, che opera quale presidio di indipendenza esterna, bilanciamento e controllo interno.
Creare due ordini distinti significherebbe organi di autogoverno separati e possibili differenze nell’approccio alle indagini e ai processi. Il rischio concreto sarebbe un indebolimento del pubblico ministero, più esposto a pressioni politiche o a priorità governative contingenti, soprattutto in una fase storica segnata da un’evidente espansione del diritto penale. Si assiste all’ introduzione di nuovi reati, all’inasprimento generalizzato delle pene, all’emanazione di misure restrittive alla libertà di manifestazione e di norme che gravano in modo selettivo su gruppi socialmente marginalizzati.
A ciò si affiancano proposte ulteriori — dalla non punibilità dell’omicidio del ladro alla cauzione per manifestare fino agli sgomberi accelerati — che pare confermino una strategia politico-criminale orientata al controllo sociale più che alla proporzionalità e alla prevenzione.
Analoga tendenza emerge nella gestione dei fenomeni migratori, tra cui: l’esternalizzazione delle procedure tramite deportazioni, contrasti con i giudici che dichiarano illegittime alcune detenzioni, misure punitive contro le ONG impegnate nei soccorsi in mare. In settori tanto politicizzati, l’azione del PM è decisiva. Un PM isolato in un ordine separato rischierebbe — anche solo per struttura istituzionale — di divenire più permeabile alle priorità governative, perdendo quel contrappeso culturale e organizzativo che deriva dalla comune appartenenza alla giurisdizione. L’attuale assetto, seppur con molteplici limiti, assicura invece maggiore coerenza nei procedimenti, omogeneità nelle strategie investigative e un contrappeso culturale interno che salvaguarda l’autonomia dell’azione requirente.
Il profilo forse più delicato riguarda la tutela delle vittime esposte a condizioni di particolare svantaggio, anzitutto economico e/o culturale. In primis donne vittime di violenza di genere e minori vittime sopravvissute ad abusi sessuali e maltrattamenti — specialmente quando i reati avvengono in contesti istituzionali di vita comunitaria chiusi, come talune realtà ecclesiastiche. Qui il PM opera accanto a ostacoli rilevanti, dove si distingue: il condizionamento del Concordato, la gestione interna e secretata del fatto di violenza – non solo sessuale – da parte dell’ente religioso, aggravata: dall’assenza dell’obbligo di denuncia nei casi di vittima minorenne, dall’omertà diffusa, dalla disinformazione, oltre che dalla pressione sociale esercitata sulla stessa e i famigliari.
L’unità della magistratura rappresenta un presidio essenziale perché evita l’isolamento del singolo PM, assicura un controllo interno omogeneo e rafforza l’indipendenza necessaria per indagare su poteri forti e tutelare chi non ha strumenti autonomi di difesa e di informazione.
Occorre riconoscere che i veri problemi della giustizia non risiedono nella separazione delle carriere, ma nella durata irragionevole dei processi, nella cronica carenza di personale amministrativo e di magistrati, nella mancanza di risorse materiali — talvolta persino della carta per le fotocopie e degli strumenti essenziali di cancelleria — e nelle disfunzioni organizzative che rallentano il lavoro quotidiano di procure e tribunali. A fronte di queste criticità strutturali, è evidente che ciò di cui il sistema ha bisogno non è una riforma simbolica che frammenta l’ordinamento, ma investimenti stabili e non burocratizzati: potenziamento degli organici, formazione tecnica culturale solida e continua, digitalizzazione realmente funzionante e semplificazione dei flussi operativi nelle cancellerie. Come accade per sanità, istruzione e lavoro, anche la giustizia richiede risorse adeguate e una visione sistemica, non interventi di facciata privi di incidenza sui problemi reali. L’incondivisibile ottica ad investire in armamenti conferma le priorità.
La logica economicista che riduce giustizia, sanità e istruzione a sistemi produttivi a basso costo accresce disuguaglianze e precarietà, minacciando non solo i servizi, ma l’equilibrio democratico complessivo. In questo contesto, la separazione delle carriere rischia di indebolire uno dei pilastri fondamentali della Costituzione: una giurisdizione forte, unitaria e realmente indipendente, capace di tutelare efficacemente le vittime più fragili, esposte a violenza, abuso e silenzio omertoso.
La conseguenza sarebbe un disequilibrio strutturale che compromette non solo l’assetto costituzionale, ma la capacità dello Stato di proteggere efficacemente le vittime più esposte alla violenza di genere, agli abusi sessuali e al maltrattamento minorile.
Roma, 14/11/2025
Avv. Mario Caligiuri
(RESP. DELL’OSSERVATORIO PER LA TUTELA DELLE VITTIME DI RETE L’ABUSO)